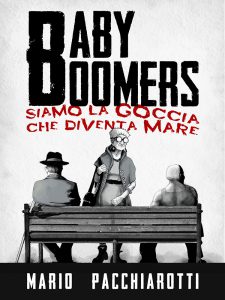Il primo capitolo di questo mio romanzo breve. Spero che vi piaccia, buona lettura…

La lampada e il libro
Prendere la metropolitana è stata una pessima idea; la folla mi soffoca, il mio naso è tormentato da odori diversi di sudore, capelli, profumi, creme, abiti stropicciati e indossati più e più volte. Non vedo l’ora di giungere alla mia fermata e ogni volta che aprono le portiere sbircio fuori per leggere il nome della stazione, ma non è mai quella e nuovi passeggeri salgono e mi spingono sempre più all’interno contro gli altri che mi circondano.
Finalmente arrivo: a fatica attraverso il muro di corpi che mi separa dall’uscita e scendo. L’aria della stazione sotterranea sembra fresca e pulita dopo quella che ho respirato nel vagone. Salgo le scale e seguo le indicazioni per piazza Le Perroquet Bleu, dove tutte le settimane c’è un mercato di cose vecchie, fra le quali una mia amica ha asserito di aver visto delle lampade che potrebbero fare al caso mio. Sono mesi che ne cerco una da tenere sullo scrittoio, ma non sono ancora riuscita a vedere qualcosa che corrisponda a quella che io immagino. La mia amica è convinta che al mercatino la troverò e siccome provare non costa niente eccomi qui. In realtà provare mi è costato moltissimo, non ricordavo quanto disagio potesse provocarmi un viaggio in metropolitana. Di solito non mi muovo dal mio quartiere, lì ho tutto quello che mi serve e lo giro quasi sempre a piedi o con l’autobus, evitando le ore di punta.
La zona in cui mi trovo adesso la conosco poco, anzi per niente. Dove sarà la piazza con il mercatino? Quasi d’improvviso mi trovo in un vicolo, che si incrocia con altri vicoli e stradette, un labirinto. Allora procedo girando sempre a sinistra: ho letto da qualche parte che questo è il metodo per uscire da un labirinto, e siccome questo è solo un garbuglio di strade, venirne fuori dovrebbe essere più facile, nonostante il mio inesistente senso di orientamento. Mentre cammino mi guardo intorno: molte abitazioni sono cadenti, ma a tratti mi imbatto in case modeste e perfettamente in ordine, dalla facciata dipinta di fresco, tende immacolate alle finestre, un piccolo giardino ben curato sul davanti. Ritagliato in una palazzina di due piani il cui intonaco è scrostato e a più di una persiana manca qualche stecca, dietro l’ultimo angolo, c’è un negozio. L’insegna, la vetrina e la porta sono in legno scuro dipinto in bianco, blu e ocra, a disegni floreali e intrecci; la pittura sembra appena fatta, è lucida e pulita, neanche una screpolatura; sui vetri leggermente fumé neppure una ditata né una traccia di insetto. Nella vetrina, su un ripiano ricoperto da un drappo giallo oro con arabeschi bruni, fra libri dalle copertine consunte e le pagine ingiallite e oggetti in ceramica e in bronzo, ecco la mia lampada. È una fortuna che i miei passi abbiano seguito la strada sbagliata.
Entro decisa e il mio passaggio è sottolineato da tintinnii e fruscii, di mille piccoli oggetti appesi alla porta e allo stipite. Odore di polvere, discreto, se non ci fosse il negozio sembrerebbe finto.
Mi avvicino al banco, che non è altro che un tavolo di legno, appoggiato su una grande zampa formata da serpenti incrociati, che con la coda si appoggiano a terra e con la testa sorreggono il piano. Il rumore che ho provocato varcando la soglia si affievolisce e, mentre mi guardo intorno, un uomo appare da dietro una tenda scura, che nella penombra sembra una parete.
Il banco è illuminato da un lampadario di cristallo dagli innumerevoli pendenti; mentre l’uomo si avvicina guardo il suo volto, ha occhi neri profondi.
Ci diamo il buon giorno, poi gli chiedo di mostrarmi la lampada in vetrina.
“Una scelta raffinata” commenta lui andandola a prendere. La posa sul banco, amorevolmente, poi si volta verso lo scaffale alle sue spalle ed estrae da un cassetto una lampadina; l’avvita, infila la spina e voilà, la mia lampada funziona; sono così concentrata su di lei che non mi accorgo nemmeno che l’uomo ha spento le altre luci per mostrarmi l’effetto al buio.
Vorrei sapere il prezzo ma esito a chiederlo: un po’ perché mi sembra un sacrilegio mescolare il denaro con un oggetto d’arte, un po’ perché temo che costi troppo per le mie tasche e allora preferisco non saperlo ancora e illudermi di potermela permettere. Lui mi legge nel pensiero, del resto è normale che adesso io stia pensando a questo, e mi dice che è un vero affare, costa pochissimo, e infatti ha un prezzo alla mia portata.
“È di valore ma l’ho avuta per pochi soldi” mi spiega e mi mostra un piccolo segno sotto la base: è il marchio della fabbrica, cioè la sigla della persona che l’ha disegnata: LR, ovvero Robert Lorier. È un nome che non ho mai sentito, non me ne intendo di queste cose.
Questo Lorier aveva un parente pittore, forse il padre o il fratello, aggiunge l’uomo, da qualche parte in bottega c’è un libro che parla di lui. Gli dico che compro la lampada e, mentre conto le banconote, lui con destrezza la sistema in una scatola tirata fuori chissà da dove. Mi chiede se deve farmela recapitare o se la porto con me. Io penso alla ressa della metropolitana, ma non voglio separarmi subito da questo oggetto che è appena diventato mio. Dirigendomi verso l’uscita abbracciata allo scatolone urto una pila di volumi che sporgono da uno scaffale. Poso la scatola in terra e mi chino per raccogliere i libri che ho fatto cadere. Lui è subito accanto a me e insieme li rimettiamo a posto. L’ultimo, mi fa notare, è proprio quello di cui mi parlava, la biografia del Lorier pittore. La copertina è di un celeste pallido, l’autore una donna che ha il mio stesso nome di battesimo, Agnes. Mi incuriosisce e decido di comprarlo ma, prima che possa dirglielo, l’uomo mi precede e me lo offre in regalo. Lo ringrazio e gli chiedo perché; lui risponde che evidentemente il libro mi stava aspettando e lui ha solo avuto il compito di custodirlo per me: c’è tanta naturalezza nella sua voce mentre lo afferma che non so replicare, per quanto trovi bizzarra la sua cortesia.
Esco. Verso occidente il sole ha insanguinato un branco di nuvole pigre distese sull’orizzonte; fra non molto scivolerà dietro le case e poi sparirà del tutto.
Percorro le strade del quartiere labirinto, e sento ancora addosso gli occhi dell’uomo, ma è uno sguardo buono, come se intendesse accompagnarmi fuori dalle viuzze tutte uguali, lo sa che sarei capace di perdermi, nonostante le indicazioni che mi ha dato. Invece arrivo alla stazione della metropolitana che ancora il cielo è rosso.
Trovo posto a sedere, così il mio bagaglio non mi crea problemi né rischio di romperlo. Poggio la scatola a terra fra le gambe e inizio a sfogliare il libro. Vengo assorbita a tal punto dalla storia che mi accorgo di essere alla mia fermata quando le portiere si sono già chiuse. Sospiro. È forte la tentazione di lasciarmi cullare dal movimento della vettura e proseguire nella lettura ma mi costringo ad alzarmi. Scenderò alla prossima stazione e tornerò indietro con il treno che va nella direzione opposta.
Quando approdo sul marciapiede il sole è ormai tramontato del tutto: la sera è quasi diventata notte e una luna tonda color zabaione se ne sta appesa lassù alla mia destra. La strada verso casa è faticosa, la scatola mi pesa sulle braccia e quando entro nel portone un cartello mi avvisa che l’ascensore nel mio palazzo è di nuovo guasto, costringendomi a fare a piedi cinque piani di scale.
L’ora di cena è vicina, ma sono stanca e non mi va di cucinare e, soprattutto, sono impaziente di leggere il libro: così mi accomodo sulla mia poltrona, illuminata da una lampada a stelo, e mi immergo di nuovo nella biografia di Claude Lorier. Quando alzo la testa verso l’orologio appeso al muro sulla parete vedo che sono già le nove passate. Ecco perché qualcosa nel mio stomaco non va; è meglio che mangi un boccone: taglio una fetta di pane, un pezzetto di formaggio e sbuccio una mela, mettendo tutto in un piatto, da tenere sulle ginocchia mentre continuo la lettura. L’equilibrio non è perfetto, ma ho conciliato i due interessi, quello degli occhi e quello dello stomaco, che smette presto di brontolare e lascia che mi dedichi in pace a Claude Lorier.
Fin dalle prime pagine ho capito che il pittore è il padre del disegnatore di lampade e anche che Agnes Gravellon, l’autrice della biografia, aveva senz’altro un rapporto profondo con Claude Lorier, di odio-amore, direi; talvolta infatti ne esalta le qualità e le opere, talaltra ne sottolinea impietosa i difetti, le meschinità. Lo critica molto, ad esempio, per il modo in cui si prende cura del figlio: a momenti di affetto totale alterna giorni in cui quasi non ne avverte la presenza. Non parla mai di una moglie, forse è morta o forse andata via, perciò il pittore deve anche colmare l’assenza della madre, ma questa responsabilità a volte se la scrolla dalle spalle, è un peso troppo grande per il suo corpo costretto su una sedia a rotelle.
L’invalidità è una buona scusa, dice sempre Agnes, un ottimo alibi dietro cui nascondersi. Ma poi si tuffa nella descrizione di un dipinto e dello stato d’animo che lo ha fatto nascere (o che lei vi legge) e allora non esiste altro che Claude Lorier pittore, senza corpo, senza difetti: il coraggio di un sentimento, di un’emozione confessati su una tela.
Mi chiedo che tipo fosse questa Agnes, tento di immaginarla da ciò che traspare di lei nella storia dell’altro e nelle parole che usa. È un lavorio continuo nella mia mente, mentre divoro pagina dopo pagina. La presenza di questa donna è forte, a tratti sembra sovrastare quella del pittore di cui si è eletta biografa. Quella che ha scritto è comunque una biografia assolutamente non convenzionale, in cui i dati oggettivi sono quasi del tutto assenti, tanto che mi chiedo se il pittore ha vissuto davvero a Varbles, come Agnes afferma, o no.
L’ultimo capitolo è breve e il tono cambia all’improvviso, diviene quasi una cronaca, ma avverto, sotto l’esposizione sintetica dei fatti, l’urlo di un dolore che cerca di restare nascosto: Claude Lorier è morto. Il linguaggio si fa scarno, essenziale, pochi cenni alla malattia che colpisce l’artista. Non trovo nessuna indicazione sul luogo in cui le sue opere sono conservate, o almeno in cui erano al momento della stampa della biografia.
Come vorrei vedere i quadri di Claude Lorier. Nel libro non c’è neanche una riproduzione e quanto descrive Agnes è più legato allo stato d’animo dell’autore e dello spettatore che all’aspetto delle tele. Le indicazioni sono frammentarie, riguardano soprattutto particolari o tecniche e poco le opere nella loro interezza: la mia fantasia mi propone delle possibili immagini ma temo che siano assai diverse dagli originali.
Andrò in biblioteca, domani, a cercare notizie su Claude Lorier e foto dei suoi quadri. Mi incammino verso la camera e vedo in un angolo la scatola con la lampada: non l’ho neppure scartata, eppure ero così contenta di averla trovata. Questo libro mi ha come stregata, forse mi sono fatta condizionare dalle parole dell’uomo del negozio, ma sento che, per me, non è un libro qualunque.
Ripetendo la frase che ha accompagnato il dono della biografia mi rendo conto che ne riecheggia in certo modo un’altra, di tanti anni fa. Una frase che, a quel tempo, ha segnato il mio destino. E adesso cosa succederà se non ignoro i richiami di Claude Lorier? Il corso della mia vita potrebbe cambiare di nuovo? Un brivido quasi impercettibile mi sale per la schiena. Allora non è stata di buon auspicio ma, alla mia età, è sciocco avere timori.